Circa un anno fa mi hanno invitata all’Università di Bologna, per parlare di sessualità e disabilità in un convegno dedicato alle Figure professionali a sostegno della disabilità adulta. Dalle riflessioni di quella calda giornata di ottobre è nato un lavoro corale coordinato da Valeria Friso e Andrea Ciani. Il libro è uscito da qualche settimana e si chiama Includere e Progettare – Figure Professionali a sostegno della disabilità adulta.
Qui un estratto del capitolo che ho scritto:
Al centro della mia riflessione c’è la considerazione della forza che hanno le rappresentazioni nel guidare i nostri comportamenti. Anzi, di più, c’è la considerazione che quel che normalmente chiamiamo la personalità di un individuo, il cuore della sua soggettività, è determinata dalle rappresentazioni, poiché l’idea di soggetto, il sentirci degli individui dotati di carattere e personalità, è innanzitutto un’auto-rappresentazione. A fianco di questa premessa vi è l’idea che il nostro rapporto con gli oggetti, con tutto ciò che è altro da noi, non sia mai immediato; in altre parole non entriamo in relazione diretta con il mondo esterno, ma questa relazione è sempre mediata da una rappresentazione, che dota gli oggetti di senso immettendoli in una catena di significati. In altre parole, non vediamo, percepiamo e concettualizziamo mai le cose per quelle che sono, ma in quanto inserite in un ordine di senso in cui si caricano di valori simbolici, utilitaristici, morali ecc.
Le nostre rappresentazioni non sono però il risultato di una libera produzione individuale ma preesistono a noi nella lingua, nella cultura in cui siamo immersi, nelle visioni e nell’universo cognitivo dei nostri genitori, parenti, amici, della nostra classe sociale ecc. Sono inoltre profondamente connesse alle relazioni materiali che regolano la riproduzione dell’esistenza umana: modi di produzione, gerarchie, forme sociali, rapporti di potere.
Questo “deposito” di rappresentazioni si esprime sotto forma di una pluralità di narrazioni, ossia come “racconti del mondo”, spesso tra loro in concorrenza, contraddittori, così come contraddittorie e talvolta paradossali sono le relazioni di cui cercano di dare conto. L’individuo nella sua evoluzione “costruisce” la propria personalità attingendo a questo straordinario repertorio di simboli, narrazioni, significati.
Ecco allora che in quell’individuo adulto, cioè in ognuno di noi, si sarà costruita una soggettività “scegliendo” tra le narrazioni che la propria variabile esistenziale (luogo di nascita, vicenda biografica, momento storico, ambiente familiare) ha messo in campo. Questa “scelta” non appare all’individuo come tale, poiché all’incontro con nuove esperienze non arriviamo mai “vergini” ma siamo già immersi in una preesistente rappresentazione. La nuova “acquisizione” sarà quindi condizionata dalle nostre rappresentazioni e sottoposta a un principio di coerenza, pena la messa in crisi dell’intero impianto rappresentativo fin lì eretto, che, date le premesse, significherebbe la messa in crisi della stessa personalità/soggettività dell’individuo.
Peraltro, se possiamo parlare di una soggettività è solo in quanto esistono degli Altri da cui ci differenziamo. Questa non è solo la condizione logica che fonda la nozione stessa di soggetto, ma è anche, nella sostanza, la premessa alla nostra auto-considerazione come individui: noi ci “vediamo” attraverso lo sguardo dell’Altro, È nell’esser guardati dagli altri che percepiamo questa nostra individualità, ossia è attraverso lo sguardo dell’Altro che noi “siamo”.
Questo semplice fatto è ricco di conseguenze: ogni nostro passo nel cammino evolutivo del nostro universo rappresentativo è fatto non solo sotto lo sguardo dell’altro, ma per lo sguardo dell’altro, dalla cui approvazione in gran parte dipendiamo.
Non va qui trascurato il fatto che per noi l’altro non è solo il singolo individuo, ma la massa degli individui nel suo insieme e le forme narrative e rappresentative depositate in un certo contesto sociale che ci preesistono, sono fuori da noi e regolano i nostri rapporti con l’Altro: la lingua, le leggi, le ideologie correnti, la morale. Dall’adesione (o anche la differenziazione e il ripudio) a questo repertorio di rappresentazioni, che sono anche una visione del mondo, dipende anche in maniera preponderante il nostro successo nelle relazioni con il mondo che è vitale per condurre un’esistenza funzionale.
Il mio lavoro è quindi centrato sulle rappresentazioni, e si estrinseca nella capacità di comprendere le fonti, il repertorio, da cui il singolo ha attinto per costruire il proprio Io. Ricostruito il quadro rappresentativo del soggetto, il lavoro procede isolando gli elementi contraddittori della narrazione che sostiene la rappresentazione (quelli che producono cioè disagio e sofferenza e che la narrazione tende ad annullare, depotenziare, nascondere). Si tratta in altri termini di decostruire le rappresentazioni, mostrandone la provenienza esterna (ossia non il frutto di un’interiorità, di quel “nucleo originario” che – nella vulgata – costituirebbe il marchio di unicità del soggetto, la sua più intima e vera personalità) e mostrandone gli incroci (biografici, psicologici ecc.) che hanno contribuito a determinare la visione cardine del soggetto, il carburante della sua personalità. Da qui, toccando i punti dolenti, quelli che spingono una persona a voler cambiare e ad abbandonare un modo di considerare la realtà e se stessi, per abbracciarne un altro, si può procedere per ricostruirne il mondo delle rappresentazioni.
Non si tratta qui di sostituire a una narrazione disfunzionale una più funzionale, nella pretesa di stabilire cosa sia giusto e bene per il singolo individuo; si tratta piuttosto di entrare in dialettica con le rappresentazioni dell’individuo – restando dentro il suo orizzonte problematico. Quel mondo di visioni, narrazioni, rappresentazioni, idee ecc., è il nucleo stesso della personalità dell’individuo, ciò che lo rende vivo e attivo ai nostri e ai suoi stessi occhi: è solo facendo emergere le contraddizioni dalle stesse istanze implicite in quell’individualità che si paleserà un’altra possibilità per il soggetto stesso, senza la perdita di quel senso di sé, di quell’auto-rappresentazione che ci definisce come soggetti.
Cosa c’entra questa premessa con il mio lavoro con i disabili? Vediamolo insieme.
La sessualità, come noi sappiamo, non è considerata tra le questioni prioritarie da affrontare per il benessere dell’individuo in disabilità, quasi che la sessualità delle persone disabili sia un’escrescenza, per lo più imbarazzante quando non fastidiosa e un po’ animalesca. In una delle narrazioni prevalenti i disabili sono eterni bambini, quindi asessuati, persone buone, da compatire, accudire, aiutare. Quando emerge, la loro sessualità è inibita, vietata, narrata come una manifestazione scomposta e incontrollata della loro diversità. E tanto più reclusa, nascosta, taciuta è la sessualità delle donne disabili. La sessualità dei disabili è quindi un problema e questa problematicità informa di sé l’universo delle rappresentazioni di cui la nostra società è portatrice.
Così succede che, influenzati da questa visione, che si sia addetti ai lavori o congiunti, nel ragionare su come rendere migliore la vita di questi individui, si tenda a omettere una questione centrale, la questione estetica. Essa, per il portatore di disabilità, è generalmente rimossa, quasi che le categorie estetiche non siano qui applicabili, quasi che non li riguardi. Il disabile viene così espulso dai territori della seduzione, dell’attrazione, della bellezza. Che gli operatori si occupino anche del disabile in termini estetici è passo necessario sulla via dell’inclusione: perché allora questa omissione? Che una persona disabile sia ritenuta brutta è considerato un fatto normale, un dato di natura, inamovibile. La disabilità sembra comporti naturalmente l’esilio dai territori dell’estetica, proprio perché vìola le leggi biologiche, è contro natura appunto. La nostra percezione della bellezza non è però un dato di natura, ma un Fatto Storico.
A condizionare la nostra concezione della bellezza sono fattori complessi che interagiscono con l’universo simbolico che ordina le relazioni umane, fattori che hanno a che fare con le gerarchie sociali, la produzione della ricchezza, i valori morali, le ideologie del corpo correnti. Sono criteri che creiamo noi, diversi in momenti storici diversi (si pensi alle donne nei quadri di Rubens, grasse e piene di cellulite, così distanti dai canoni di bellezza attuali). Ma riconoscere e assumere questa idea della costruzione sociale e culturale dei canoni di bellezza e della loro relatività storica potrebbe non bastare a evitare il pregiudizio sull’estetica del disabile. Qualcuno potrebbe dire che, al di là delle variabili storiche, la percezione negativa dell’estetica del disabile dipenda dalla linea di demarcazione – chiara e distinta – tra abili e non, valida in ogni contesto e che i disabili non sono belli mai.
Ma la storia ci insegna che questa linea di demarcazione è tutt’altro che netta, e che a soggetti in evidente condizione di disabilità è stata attribuita una valenza estetica positiva.
Il bendaggio dei piedi delle donne cinesi inizia intorno al 900 d.C. e dura fino all’inizio del XX secolo. I piedi venivano ripiegati su sé stessi e fasciati in modo da rimanere per sempre non più lunghi di 8 cm. Questo procedimento rendeva le donne incapaci di muoversi autonomamente, più esposte a infezioni e malattie dovute allo stato dei piedi così costretti. Ma la pratica fu portata avanti per 1000 anni perché gli uomini dicevano che: “Un piccolo piede testimonia l’integrità di una donna”; “Un piede piccolo è morbido e toccarlo è estremamente eccitante”. Una donna con i piedi naturali generava orrore e repulsione. Milioni di donne furono sottoposte a gravi ferite per un millennio, storpiate e rese disabili nel nome dell’erotismo e della bellezza.
Se non bastasse questo esempio, diamo un’occhiata all’abbigliamento delle donne europee dall’epoca elisabettiana in poi, per un lungo periodo. Il busto (o corsetto) era l’indumento che costringeva dalla vita in su, fino al seno, in una gabbia strettissima il corpo femminile. Il fisico così costretto, subiva trasformazioni esteriori ma, soprattutto, più pericolose deformazioni interne. Tutti gli organi interni erano compressi verso l’alto provocando disturbi digestivi, emorragie interne, svenimenti. Le cronache narrano di alcune giovani donne morte per aver indossato corsetti talmente stretti che le costole avevano trafitto loro il fegato. Il Fontange (nome preso da una delle amanti di Luigi XIV) era un complicato sistema per acconciare i capelli, ricco di nastri, merletti, pizzi e strutture molto ingombranti, pesanti e difficili da indossare. Le donne che lo indossavano, soffrivano spesso di dolori al collo causati dallo schiacciamento delle vertebre cervicali ed erano soggette a perdita dei sensi. Nella storia dei canoni estetici una pagina importante è caratterizzata dalla pelle candida. Avere la carnagione pallida come porcellana era simbolo di ricchezza e di nobiltà. I trucchi che le donne utilizzavano, erano composti da ingredienti pericolosissimi come piombo e arsenico. Questo tipo di veleni ha bisogno di tempi molto lunghi per manifestare il proprio effetto. I sintomi di avvelenamento da piombo sono numerosi: mal di testa, inappetenza, anemia, paralisi, insonnia e un gusto metallico costante in bocca, tutti disturbi che i medici riscontravano frequentemente nelle donne dell’epoca.
Insomma, le donne (e gli uomini) nei secoli e in tutte le parti del mondo hanno subito e si sono prodotte danni irreversibili al corpo, entrando di diritto nel mondo della disabilità, per quanto procurata. Perché quelle donne, disabili a tutti gli effetti, sono state e sono considerate belle ed eccitanti? Perché quella disabilità, quel modello estetico, è stato ed è accettato socialmente? In forza delle rappresentazioni che orientano il gusto estetico. E qui veniamo finalmente al punto di congiunzione tra il mio lavoro, la sua impostazione e la questione della sessualità in disabilità. Quando parliamo di estetica parliamo di rappresentazioni. E come variano storicamente i canoni estetici variano anche le nostre rappresentazioni, che ne sono al contempo causa e conseguenza.
In questo quadro, come si integrano le mie posizioni teoriche generali con il mio operare con la disabilità? Anche qui abbiamo a che fare con un universo rappresentativo, sorretto da una narrazione profondamente ideologica, che vede il disabile collocato ai confini dell’estetica e sostanzialmente annullato sotto il profilo della personalità sessuale. Su questo contesto opera il lavoro di decostruzione di questa impalcatura, fino a isolare i nodi contraddittori che pongono da un lato la pulsione sessuale del disabile e dall’altro l’assenza di una sua possibilità di espressione. Il che significa sia che non c’è depositata nelle rappresentazioni correnti una dimensione narrativa che consenta l’espressione sessuale del disabile, ma che manca anche il vettore fisico/individuale, la personalità sessuale (la auto-rappresentazione del disabile e del proprio corpo come strumento di piacere sessuale) che possa sostenere la pulsione dandogli un possibile sbocco.
Il mio lavoro consiste allora nello scardinare il nucleo ideologico di queste rappresentazioni, nel creare una distanza da queste rappresentazioni, così come sono interiorizzate dai singoli, per generare una nuova consapevolezza. La decostruzione della rappresentazione e il suo riconoscimento quale costruzione sociale, aiuta l’emersione fluida, fin qui ostacolata, della sessualità del disabile avviando un processo che mira ad ampliare l’universo delle rappresentazioni e farle diventare aperte e inclusive. Un nuovo modo di vedere, che gli restituisca la sua personalità sessuale, il suo ruolo attivo di seduzione attrazione, anche attraverso la cura di sé e il proprio inserimento nell’universo delle relazioni con l’altro come soggetto estetico.
Il mio modo di operare si articola in quattro momenti:
1. Processo di acquisizione della consapevolezza che la vita sessuale delle persone è governata dalle rappresentazioni.
2. Esplorazione approfondita dell’universo rappresentativo e sua connessione con le narrazioni correnti nel contesto sociale e culturale dato.
3. Decostruzione delle rappresentazioni, individuando i nodi delle relazioni familiari, sociali, culturali in cui la rappresentazione si è costituita.
4. Individuazione dei nodi contraddittori che limitano l’espressione delle pulsioni sessuali.
A questa fase segue un lavoro di apertura a nuove rappresentazioni, in grado di accogliere e permettere l’espressione della vita sessuale, rappresentazioni che “parlino” e interagiscano con l’universo cognitivo del disabile e aprano alla consapevolezza di sé come soggetto sessuale.





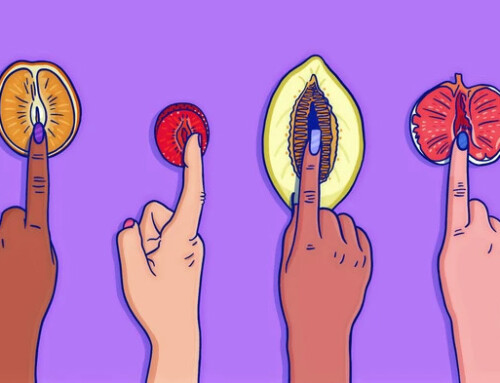


Leave A Comment